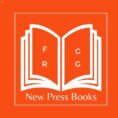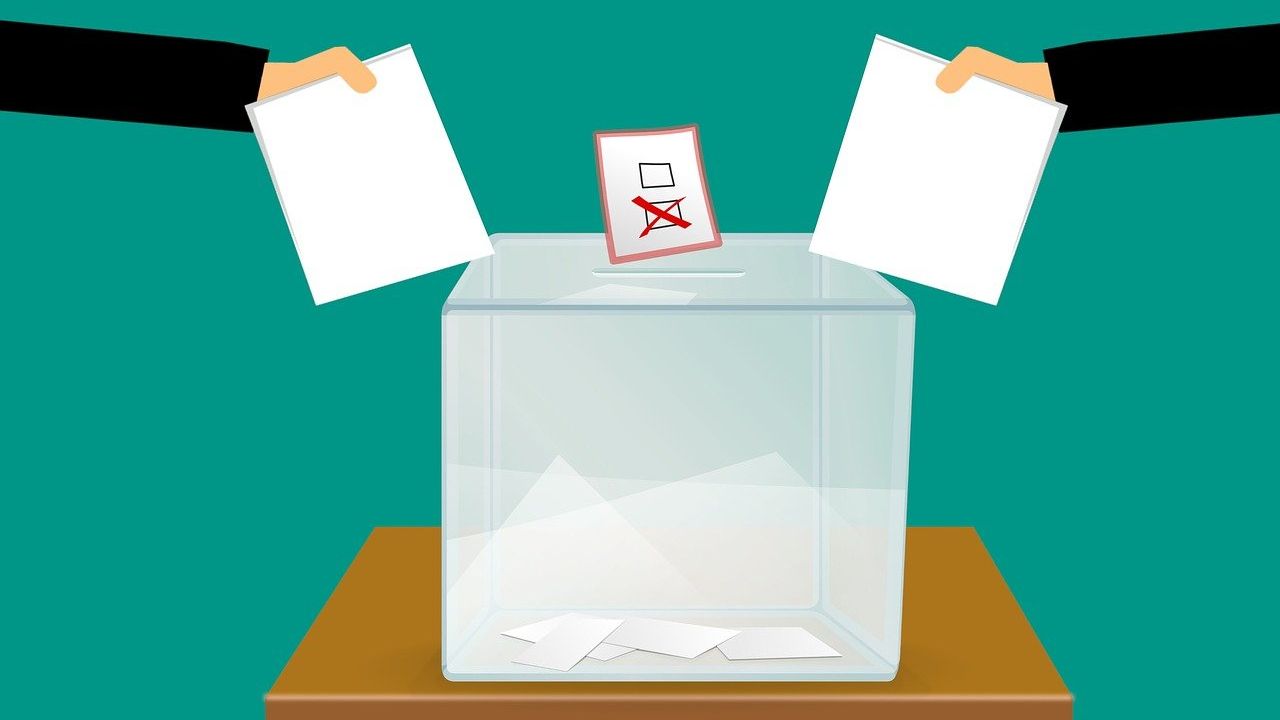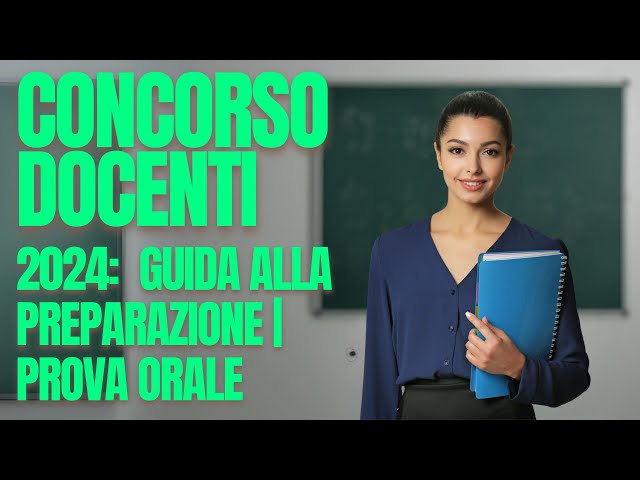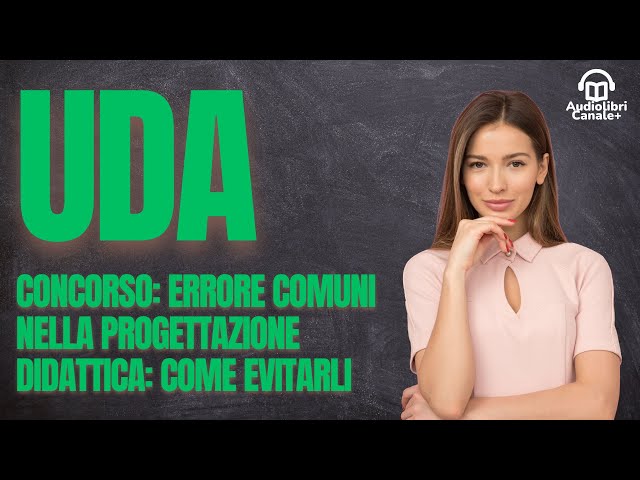Il Referendum sulla cittadinanza italiana si terrà l’ 8 e 9 giugno. Questa consultazione popolare è un’occasione per i cittadini di esprimere direttamente la propria volontà su questioni rilevanti che plasmano il futuro del Paese. Riguarda in modo specifico l’acquisizione della cittadinanza da parte di persone con background migratorio. La Fondazione ISMU si dedica a fornire informazioni e strumenti per contrastare la disinformazione e la polarizzazione sul tema, promuovendo un dibattito informato e aiutando i cittadini a esercitare consapevolmente il loro diritto di voto, senza schierarsi “per il sì” o “per il no”.
Il quesito referendario: cosa c’è in gioco?
Il referendum è abrogativo e il quesito chiede di abrogare specifiche parti dell’articolo 9, comma 1, lettere b) e f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina le nuove norme sulla cittadinanza. In termini sostanziali, il referendum si propone di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia richiesti allo straniero che chiede la concessione della cittadinanza. Questa modifica ripristinerebbe un requisito di residenza che era in vigore in Italia prima della legge del 1992, specificamente quello previsto dalla legge del 1912. È cruciale comprendere che questo referendum non interviene sugli altri requisiti necessari per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione. Tali requisiti, che rimarrebbero invariati, includono:
- La conoscenza della lingua italiana.
- Un reddito di una certa entità.
- L’incensuratezza penale.
- L’ottemperanza agli obblighi tributari.
- Il non rappresentare un pericolo per la sicurezza del Paese.
Perché votare: cittadinanza e integrazione
Il referendum sull’acquisto della cittadinanza è considerato di particolare importanza. L’acquisizione della cittadinanza è strettamente legata ai percorsi d’integrazione degli stranieri, una questione fondamentale per il futuro del nostro Paese. Sebbene l’integrazione sia influenzata da molteplici fattori, tra cui il lavoro e l’atteggiamento reciproco tra società ospite e immigrati, i modi d’acquisto della cittadinanza giocano un ruolo rilevante nel favorire o ostacolare questi processi.
I tempi per l’acquisizione contano, eccome. L’acquisto della cittadinanza è definito come un momento chiave nel percorso di vita degli immigrati. Ridurre il tempo di attesa da dieci a cinque anni può avere un impatto significativo anche sui percorsi di vita dei figli minorenni. Se un genitore ottiene la cittadinanza italiana, può trasmetterla ai figli, ma solo se questi sono minorenni. Diminuire il tempo di attesa consentirebbe a molte più ragazze e ragazzi, altrimenti destinati a diventare maggiorenni “da stranieri”, di ottenere la cittadinanza attraverso i genitori.
Stabilire il tempo e il modo migliore per l’acquisto della cittadinanza è una scelta complessa, influenzata da diversi percorsi di vita e variabili da considerare. Il concetto stesso di integrazione non è univoco. La decisione finale è squisitamente politica, ma ISMU ritiene sia bene che sia fondata su una reale conoscenza dei fatti.
Il confronto: Italia ed Europa sui tempi di attesa
La disciplina attuale in Italia, che richiede dieci anni di residenza legale ininterrotta per la naturalizzazione (salvo specifiche eccezioni per rifugiati o cittadini UE), è più restrittiva rispetto alla prassi prevalente in altri Paesi europei. Prima della legge del 1992, la legislazione italiana prevedeva generalmente cinque o sei anni di attesa. La legge del 1912, in vigore fino al 1992, richiedeva cinque anni. Il passaggio a dieci anni nel 1992 avvenne senza un dibattito particolarmente approfondito sul tema.
In caso di vittoria del “Sì” referendario, richiedere cinque anni di residenza per la naturalizzazione rappresenterebbe un allineamento con la prassi prevalente in Europa. Ad esempio, la Germania ha recentemente modificato la sua normativa, convergendo sulla regola dei cinque anni di previo soggiorno, spesso accompagnata dalla valorizzazione dei “corsi di integrazione”. Tuttavia, come sottolineato, i tempi di attesa non sono l’unico aspetto da considerare nel confronto europeo.
Acquisizioni di cittadinanza in Italia: i dati reali
I dati sull’acquisizione della cittadinanza in Italia mostrano numeri consistenti. Secondo le statistiche ISTAT, negli ultimi anni (dati provvisori 2024 e definitivi 2023), i nuovi cittadini italiani sono stati oltre 200.000 all’anno. Questo dato è significativamente più alto rispetto alle percezioni di una parte del pubblico, come emerso da un quiz ISMU. Le modalità di acquisizione sono diverse. Le principali includono:
- Trasmissione dai genitori o acquisizione per i diciottenni: Circa il 48% delle acquisizioni totali. Questo dato è rilevante perché i figli minori acquisiscono automaticamente la cittadinanza se il genitore diventa italiano.
- Naturalizzazione per residenza: Riguarda circa il 40% delle acquisizioni. Questa è la modalità al centro del dibattito referendario.
- Acquisizione per discendenza (ius sanguinis) e matrimonio: Rappresentano quote minori, con il matrimonio che negli anni è diventato meno rilevante (circa 12%) rispetto al passato.
Una quota considerevole dei nuovi cittadini è costituita da persone giovani. Nel 2023, il 48% dei nuovi cittadini aveva fino a 30 anni, inclusi 78.000 casi sotto i 20 anni. Le nazionalità di origine dei nuovi italiani sono molto eterogenee, non dominate da un singolo gruppo. Le comunità storicamente più consolidate in Italia (Albania, Marocco) sono tra quelle con il maggior numero di acquisizioni, ma anche persone da Argentina, Brasile (spesso per discendenza) e Romania contribuiscono significativamente. Questa eterogeneità dimostra che non c’è uno “stravolgimento” monolitico della composizione della popolazione italiana.
Tra pregiudizi e burocrazia: le sfide del percorso
Il dibattito pubblico sulla cittadinanza è spesso condizionato da stereotipi e pregiudizi, con narrazioni scorrette che non riflettono la realtà. Concetti come la “sostituzione etnica” o la “cittadinanza regalata” non trovano riscontro nei fatti. Il percorso per ottenere la cittadinanza, anche con i requisiti attuali, è descritto come complesso e burocraticamente impegnativo. La necessità di una residenza legale ininterrotta può rappresentare una difficoltà notevole. Brevi interruzioni possono compromettere l’esito della domanda, come testimoniato da esperienze personali.
Esiste una tensione tra la concezione della cittadinanza come una “concessione” o “premio” (terminologia usata anche nella legge italiana attuale per la naturalizzazione) e una come “diritto” o “riconoscimento”. Per i figli di immigrati, in particolare, il mancato riconoscimento come parte integrante della società italiana può generare sofferenza e influenzare la loro identità e proiezione nel futuro.
La cittadinanza non è solo una questione burocratica, ma garantisce l’accesso a diritti politici fondamentali come il diritto di voto e di eleggibilità. Questi diritti sono cruciali per la piena partecipazione alla vita democratica e civica del Paese.
Referendum e partecipazione: il contesto politico
Le posizioni dei partiti politici in vista del referendum sono diverse. Diversi partiti di opposizione hanno espresso un orientamento per il “Sì”, mentre il Movimento 5 Stelle ha lasciato libertà di voto. Alcuni partiti della maggioranza di governo hanno indicato l’astensione come orientamento, una strategia che mira a non far raggiungere il quorum di partecipazione necessario per la validità del referendum (la metà più uno degli aventi diritto al voto). Secondo alcuni sondaggi, la partecipazione attesa per questo referendum potrebbe essere bassa, riflettendo una tendenza più ampia nella storia referendaria italiana, anche se l’esito non è scontato.
Decidere se votare “sì” (ritenendo 10 anni “troppi”) o “no” (ritenendo 10 anni il tempo “giusto”), o lasciare scheda bianca, sono tutte soluzioni considerate ragionevoli se basate su una conoscenza reale. La partecipazione è comunque un valore in democrazia, specialmente su questioni di particolare importanza.
Il Referendum sulla Cittadinanza del 8-9 Giugno invita i cittadini a una riflessione profonda sui requisiti per l’acquisizione, sul significato dell’integrazione e sull’identità nazionale in una società sempre più plurale. Informarsi è il primo passo per partecipare consapevolmente a questa importante decisione. La Fondazione ISMU mette a disposizione analisi, dati e approfondimenti per supportare i cittadini in questo percorso. Basta collegarsi al loro sito o al canale YouTube.
Visita le nostre selezioni formative per la scuola: Visita il sito